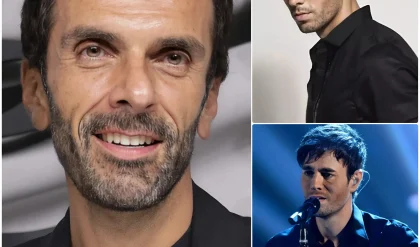La sorellanza profana: le donne d’élite di Richmond che condividevano i loro schiavi maschi (1849)
Richmond, Virginia, 1849. Era una città avvolta dalla prosperità e profumata dalle ricchezze del tabacco. Le sue dimore signorili lungo Church Hill erano monumenti alla raffinatezza, alla fede e alla virtù del Sud. Ma dietro quelle carte da parati francesi importate e le porte chiuse dei salotti, qualcos’altro stava prendendo forma, qualcosa che un giorno avrebbe sconvolto i palazzi del potere in Virginia e lasciato una macchia indelebile sulla sua elegante società.

Tra marzo e novembre di quell’anno, diciassette schiavi scomparvero dai registri delle famiglie più prestigiose di Richmond. I registri ufficiali dichiaravano che erano stati venduti a piantagioni più a sud. Tuttavia, nessuna nave riportava i loro nomi e nessuna fattura di vendita corrispondeva ai trasferimenti. Ciò che i registri nascondevano non era un errore amministrativo, ma un segreto che avrebbe costretto l’assemblea legislativa della Virginia a convocare una sessione d’urgenza e a sigillare le sue conclusioni per settantacinque anni.
Le stanze nascoste di Church Hill
Al centro di questo scandalo c’erano otto donne – mogli di giudici, banchieri e mercanti – che formarono quella che in seguito sarebbe stata chiamata la Sorellanza Profana. Per il mondo, erano modelli di decoro: mecenati di opere di beneficenza, decoratrici di chiese e direttrici di salotti raffinati. Ma da quella primavera in poi, i loro incontri del martedì e del giovedì pomeriggio assunsero un significato più oscuro.
La leader era Catherine Harrowe, quarantatré anni, una vedova ricca e intelligente che gestiva l’impero del tabacco del defunto padre con silenziosa autorità. Suo marito, giudice di tribunale, era spesso assente. In sua assenza, Catherine iniziò a tenere “riunioni private” nella loro villa di Franklin Street: riunioni a cui partecipava solo una cerchia ristretta di donne e un numero altrettanto esiguo di domestici.
Quei servi erano schiavi, scelti per la loro giovinezza, forza e obbedienza. E non erano lì per servire il tè.
Cominciò, come spesso accade in questi orrori, con una trasgressione. Catherine chiamò il suo servitore personale, Samuel, per spostare i mobili. Quando lui entrò, chiuse la porta. Gli offrì il tè, un gesto che sfidava tutte le regole del suo mondo. Poi iniziò a parlare di solitudine – di un matrimonio basato sul dovere più che sull’affetto – e oltrepassò un limite da cui nessuno dei due poteva tirarsi indietro.

Nel giro di una settimana, Catherine si confidò con la sua amica d’infanzia Eleanora Randolph, discendente della famosa dinastia della Virginia. Quella che era iniziata come una confessione sussurrata divenne presto un’abitudine. Ad aprile, altre sei donne – mogli di banchieri, magnati del tabacco e giudici – avevano seguito il suo esempio.
Con amara ironia si definivano la Sorellanza della Carità.
I macchinari minerari
Entro l’estate, la Confraternita aveva creato un sistema tanto segreto quanto depravato. Facevano ruotare gli schiavi tra le famiglie con falsi pretesti, quindi l’assenza di servi destava sospetti. Tenevano doppi registri: uno per gli occhi dei mariti e l’altro per registrare le loro effettive attività in un linguaggio in codice. Usavano segnali, frasi e osservatori per garantire la privacy.
Gli uomini non avevano scelta. Rifiutarsi avrebbe significato frustate, essere venduti o rappresaglie contro le loro famiglie. Alcuni tornarono a casa silenziosi e distrutti; altri divennero gusci vuoti di se stessi. Negli alloggi degli schiavi di Richmond, le loro mogli notarono i cambiamenti: gli uomini che un tempo portavano dignità negli occhi ora fissavano solo il basso.
Una donna di nome Rachel, una domestica che aveva cresciuto il suo amante fin dall’infanzia, osò affrontare la sua datrice di lavoro, Margaret Wickham, una discendente dei primi coloni di Jamestown. “Non puoi fare questo a questi uomini senza corrompere tutto ciò che tocchi”, disse. La risposta di Margaret fu gelida: “Se tieni alla sicurezza di tua figlia, non ne parlerai mai più”.
Rachel obbedì, ma tra le donne schiave di Church Hill iniziarono a diffondersi voci. Seguirono silenziosi atti di sfida: pasti avariati, lettere smarrite, chiavi smarrite: piccoli atti di sabotaggio per interrompere i rituali osceni dei loro amanti.
Il ricorrente

Fu Samuel a rompere finalmente il silenzio. Istruito in segreto, sapeva leggere, una rarità tra gli schiavi. Quando scoprì che Eleanora Randolph teneva un diario in codice delle sue attività, lui e un altro schiavo, Isaac, corsero un rischio enorme. Una sera, mentre Eleanora partecipava a una cena, irruppero nella sua scrivania, copiarono diverse pagine e le portarono al reverendo William Thompson, pastore della chiesa episcopale di St. John.
Thompson era un uomo di fede austera e uno dei pochi a Richmond che osava parlare pubblicamente del decadimento morale che la schiavitù generava sia nei padroni che negli schiavi. Quando Samuel descrisse le “riunioni” della Confraternita, l’incredulità del Reverendo cedette il passo all’orrore. Lui e Samuel decifrarono il codice di Eleanora alla luce di una lampada. Le annotazioni erano esplicite, metodiche e schiaccianti.
Thompson portò le prove al vescovo William Meade, capo della Chiesa episcopale della Virginia e uno degli uomini più potenti dello Stato. “Se questo è vero”, disse Meade dopo aver letto le pagine, “rappresenta una corruzione morale così profonda che faccio fatica a comprenderla”.
Il 10 settembre 1849 il vescovo convocò un’indagine segreta, convocando cinque uomini di “carattere irreprensibile” (un commerciante, un medico, un avvocato, un proprietario di piantagioni e un professore) per ascoltare le loro testimonianze.
L’indagine che ha scosso la Virginia
Durante una lunga giornata trascorsa in una stanza sigillata della chiesa di St. John, Samuel e Isaac testimoniarono. Le loro voci, ferme e prive di emozioni, descrivevano lo sfruttamento sistematico che avevano subito. Poi fu la volta di Rachel, che raccontò le minacce contro la figlia. Infine, un medico di Richmond confermò le loro storie e rivelò che una delle donne lo aveva chiamato lamentando “disturbi femminili” compatibili con ripetuti rapporti sessuali.
Al calar della notte, la commissione concluse che le prove erano inconfutabili. Il vescovo Meade redasse un rapporto formale e lo consegnò al governatore John Floyd la mattina seguente. Floyd lo lesse in silenzio, con il viso arrossato. “Capisce cosa mi sta consegnando, vescovo?” disse. “Se questa notizia venisse fuori, distruggerebbe alcune delle famiglie più potenti della Virginia”.
Tuttavia, Floyd accettò di agire. Entro tre giorni, convocò una sessione d’urgenza dell’Assemblea generale della Virginia, una riunione così segreta che persino ai segretari fu impedito di entrare nell’aula.
La notte in cui Virginia affrontò se stessa

Il 14 settembre 1849, il governatore Floyd si rivolse ai legislatori riuniti:
“Signori, vi ho convocati qui oggi per affrontare una questione di così grave importanza morale che mi riesce a malapena di trovare le parole. Ciò che sto per presentarvi vi sconvolgerà. Ma la giustizia, per quanto dolorosa, deve essere il nostro principio guida.”
Lesse alcuni estratti del rapporto d’inchiesta. Calò il silenzio. Gli uomini che conoscevano quelle donne da decenni erano pallidi e tremanti. Un senatore, imparentato con una delle imputate, pianse apertamente.
Il dibattito esplose. Alcuni chiamarono le donne mostri. Altri diedero la colpa agli uomini schiavizzati. “Hanno sedotto i loro amanti!” urlò un parlamentare. Ma un delegato più giovane, Samuel McDow, si alzò con un discorso che sarebbe stato ricordato a lungo, anche dopo che il suo nome fosse scomparso dalla storia.
“Queste donne non hanno semplicemente commesso adulterio”, ha detto. “Hanno sfruttato sistematicamente esseri umani su cui avevano potere assoluto. Questa non era seduzione. Questa era coercizione, pura e semplice. Se ci rifiutiamo di agire, dimostriamo che in Virginia la legge è scritta solo per i potenti”.
Dopo mezzanotte, l’assemblea votò. Le otto donne sarebbero state accusate di adulterio e “corruzione morale”, ma venne loro offerta una scelta: un processo pubblico e il disonore, oppure l’esilio permanente e la confisca totale dei loro beni.
Quanto agli uomini, l’assemblea decretò che sarebbero stati acquistati dai loro proprietari e liberati, ma esiliati dalla Virginia dopo trenta giorni. Erano troppo pericolosi, troppo simbolici, per essere lasciati lì.